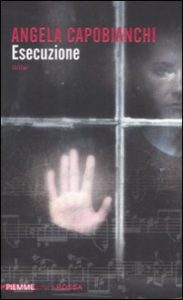"Tutto ciò di cui hai vissuto e vivi è una menzogna, un inganno, che ti nasconde la vita e la morte." E non appena lo pensò, si levò il suo odio e insieme con l'odio le penose sofferenze fisiche e con le sofferenze la consapevolezza di una morte inevitabile, prossima. Prese forma qualcosa di nuovo, che cominciò a trapanare, a produrre dolori lancinanti, e a soffocargli il respiro."
Si può parlare di finzione in modi differenti. In sensi differenti. Anzitutto di finzione come "messa-in-scena" - parola evocativa, inevitabilmente, di immagini che rimandano al mondo della rappresentazione, in particolare di quel tipo di rappresentazione che definiamo "teatrale". Di finzione/imbroglio in senso archetipico (1) ovvero di "trick", se riferita al contesto di rituali che si collochino all'interno di un processo di trasmissione di particolari tipi di conoscenze, come quello caratteristico dell'iniziazione sciamanica (e qui mi sovviene l'esemplare saga di Carlos Castaneda e dei suoi leggendari protagonisti (2)). C'è tuttavia, tra i diversi, un senso molto più - per così dire - immediato, ingenuo, fenomenologicamente parlando, d'intendere l'idea di finzione. La finzione come pura e semplice menzogna, inganno. Sia se riferita al rapporto con sè stessi ("auto-inganno", "malafede" nel senso sartriano) o al rapporto con gli altri. Tra le differenti accezioni del termine sussiste un'indubbia relazione, che al limite tende a far svanire i confini concettualmente e contestualmente stabiliti tra l'una e l'altra forma. "La morte di Ivan Il'ic" è un racconto breve (3), capolavoro della letteratura russa, in cui l'autore, Lev Tolstoj, con minuzia di dettagli e la capacità di descrizione fenomenologica che è appannaggio dei grandi scrittori, narra le vicissitudini psicologiche antecedenti alla morte del protagonista, Ivan Il'ic Golovin, consigliere di Corte d'Appello, esito di una malattia misteriosa che ripetuti consulti medici non sono stati in grado di diagnosticare con certezza. Ivan Il'ic è stato per tutta la vita quello che coloro che non sono saturi di "psicopatologia" definirebbero un uomo sostanzialmente "equilibrato", "normale". Marito e padre di due figli, un maschio e una femmina, suo padre era un funzionario pietroburghese che "...in vari ministeri e dipartimenti, aveva fatto la carriera che conduce le persone a quella posizione in cui, anche se appare chiaro quanto esse siano inadatte a svolgere una qualunque sostanziale mansione, tuttavia per il loro lungo e trascorso servizio non possono essere licenziate e ottengono perciò fittizi posti inventati, in cambio di non fittizie migliaia di rubli (...) con le quali approdano all'estrema vecchiaia"
La vita di Ivan, a parte qualche trascurabile conflitto coniugale derivante da disaccordi sull'educazione e gli studi da far intraprendere ai figli, scorre tranquilla tra impegni di lavoro, partite a "vint" (4) con amici e colleghi, e le preoccupazioni per la "sistemazione" della figlia maggiore, alla cui mano aspira il rampollo di una famiglia ben in vista della società pietroburghese del tempo. Ha quarantacinque anni quando, nel pieno di questa vita normale, inizia ad accusare i primi sintomi della malattia che lo porterà nel giro di pochi mesi alla morte
"Aveva uno strano gusto in bocca e avvertiva un fastidio nella parte sinistra dello stomaco"
Iniziano allora le visite, i consulti medici, con tutta la ritualità del caso. Ma inizia parallelamente, nel corso della narrazione, un processo di progressivo estraniamento del protagonista, che da questo momento in poi inizierà ad osservare e percepire sempre più distintamente la rete di falsità, di finzioni ed elusioni, che la malattia finirà col tessere intorno a lui, nei rapporti con le persone che lo circondano, ad iniziare dai familiari. Non si direbbe tuttavia che si tratti di qualcosa di "nuovo" (neo-), nel vero senso della parola. A ben vedere, sembra che tutto quanto inizia ad essere registrato e còlto dal protagonista fosse già presente, dall'inizio della narrazione. Si direbbe che da mero personaggio all'interno del racconto, immerso in "dinamiche psicologiche" di cui era sostanzialmente inconsapevole, - o meglio che non attiravano la sua attenzione - , il suo punto di vista, il suo vertice di osservazione, con la comparsa della malattia tende ad avvicinarsi progressivamente a quello dell'autore del racconto - ovvero del suo ... Creatore. Se all'inizio noi lettori potevamo cogliere dal tono e dai contenuti della descrizione dell'Autore del mondo di Ivan le piccinerie, la grettezza, le menzogne e le finzioni di un'esistenza assai comune, col trascorrere del tempo, e delle ... pagine, e l'inesorabile avvicinarsi della morte (del protagonista e ... del racconto), avviene una sorta d'osmosi psicologica tra i due. Come se per il personaggio Ivan l'approssimarsi della morte sia, allo stesso tempo, il progressivo ri-assorbimento del suo essere nell'essere di colui che gli ha dato vita, immaginandolo. "Morte" come limite rispetto ad un disvelamento incipiente, perennemente "in progress", stando alla fenomenologia del vissuto di Ivan I'lic. Disvelamento che, strada facendo, spietatamente mette a nudo agli occhi del protagonista quelle verità che finchè era "sano" non gli era dato di cogliere, almeno non con tanta chiarezza. I ripetuti consulti medici sembrano avere il solo scopo di stabilire una suggestiva "sanzione" della morte, la sua estromissione dalla consapevolezza nell'incontro interpersonale tra il protagonista e gli altri, "i sani", essenzialmente i suoi congiunti, che tuttavia fallisce nel tacitare il confronto intrapsichico del protagonista con la morte, che al contrario è soggetto ad un crescendo continuo, fino all'incalzante finale. Nel racconto aleggia un'atmosfera ipnotica che sembra miri a detonare, rifrangere, eludere, sviare ed ingannare il senso della morte, l'acuta percezione del suo incombere nella coscienza del protagonista. Fino alla fine egli "colluderà" con tutto questo, lungi dall'essere mero "soggetto passivo" delle manovre relazionali altrui. L'impressione è che tutto ciò, benché molto umano, finisca con l'accentuare la sofferenza e l'isolamento del protagonista, in un crescendo in cui dolore fisico e psichico sembrano perdere progressivamente ogni distinzione. La morte come cifra, confronto ineludibile con una verità soggettiva e non condivisibile con alcuno, sembra qui farsi paradigma di un cammino individuativo attraverso cui sempre più serratamente la percezione del singolo coglie i limiti della prossimità, delle possibilità di relazione, chiamato a sopportare il peso di una implacabile resocontazione intima di tutti gli inganni perpetrati (verso se stesso e verso gli altri) nel tempo speso coltivando l'illusione che l'evento estremo - come suggeriva Freud parlando dell'inesistenza della morte per l'inconscio - sia qualcosa che non ci riguardi realmente e personalmente, e che la "vita" e il "mondo" siano ... "cosa nostra", nel tempo e nello spazio.
"(...) In quello stesso istante Ivan Il'ic sprofondò, vide la luce, e gli fu rivelato che la sua vita non era stata come avrebbe dovuto, ma che la si poteva ancora correggere. Si domandò : "che significa come si deve?" e tacque, mettendosi in ascolto. In quel momento sentì che qualcuno gli stava baciando la mano. Aprì gli occhi e guardò il figlio. Provò pena per lui. Gli si avvicinò la moglie. La guardò. (...)provò pena per lei. "Già, li sto tormentando." pensò. " Provano pena per me ma staranno meglio, quando sarò morto. Fece per dirlo ma non ebbe la forza di articolare i suoni (...)"
La storia si conclude con una sorta di dolorosa "consegna", che il gesto affettuoso del figlio, tra le lancinanti sofferenze dell'agonico protagonista del racconto, sembra sancire. La consegna di un non senso, di un'irriducibilità della morte - e della vita - all'ordine di qualunque tipo di discorso. Anche questa, naturalmente, è soltanto un’interpretazione, certo poco palliativa e impietosa - a differenza di quell'ultimo, tenero gesto filiale - che non scioglie il nocciolo di mistero e angoscia che aleggia dappertutto in questo magistrale racconto; così onesto, così sincero, in contrasto colle piccole, grandi meschinità e le finzioni del vivere quotidiano, sociale e familiare, al di la' del tempo e del mondo in cui è ambientato.
Note
1) Sono esemplificativi al riguardo gli studi condotti da Jung e Kerènyi sulla figura del "Briccone Divino"
2) Si raccomanda, in merito, l'introduzione di F. Jesi al resoconto delle "esperienze" narrate da Carlos Castaneda nel suo libro "L'isola del tonal", relative al presunto "apprendistato sciamanico" a cui sarebbe stato sottoposto l'autore, negli anni '60 del secolo scorso, da parte di due "stregoni" Yaqui (una popolazione di nativi americani stanziati nel Messico settentrionale).
3) Pubblicato la prima volta nel 1886.
4) Si tratta di un gioco di carte russo, simile al più noto "Bridge".
Riferimenti bibliografici
Castaneda C. 1974, "L'isola del tonal", Rizzoli, Milano 1975
Miceli, S. 1984 "Il demiurgo trasgressivo. Studio sul trickster", Sellerio, Palermo, 2000
Radin, P., Jung, C. G., Kerényi K. (1954), "Il briccone divino", Bompiani, Milano, 1965
Tolstoj L. 1886, "La morte di Ivan Il'ic", Garzanti, Milano